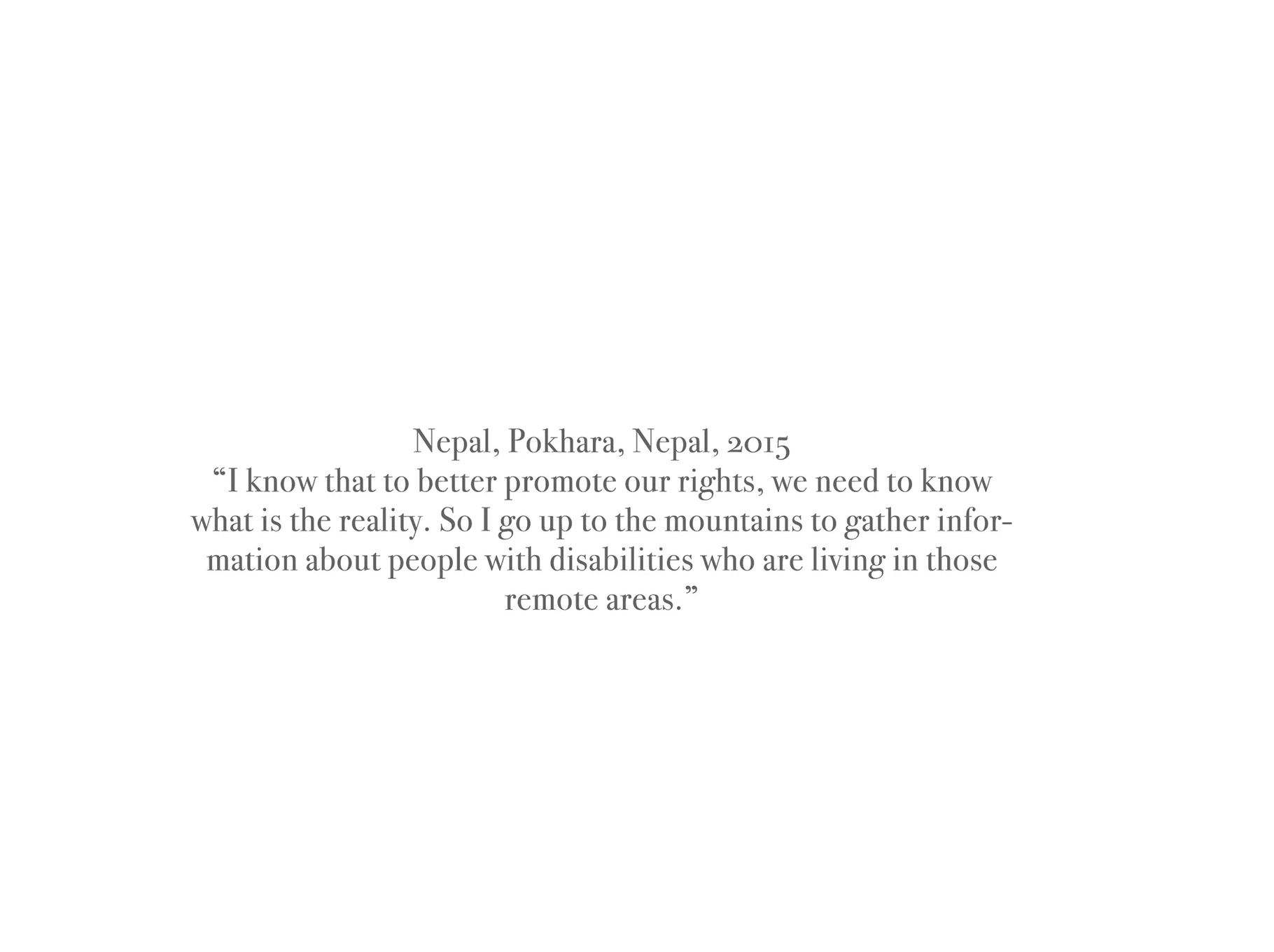Christian Tasso cambia il modo di vedere dietro l’obiettivo, ora nessuno è escluso
Il vero viaggio è avere nuovi occhi per guardare il mondo e la realtà che ci circonda. Lo diceva Marcel Proust, l’ha applicato il fotografo Christian Tasso nei suoi scatti alle persone con disabilità. E se si guardano le foto del suo libro, Nessun Escluso, ci si accorge subito del perché: il problema delle persone ritratte non emerge, e spesso si fatica anche a capire se abbiano o meno una disabilità. Così ha voluto il suo lavoro, e così ha raccolto le loro storie, provenienti da tutto il mondo. Una ricerca che inizia più di 10 anni fa, che lo ha portato a trasformare radicalmente il suo punto di vista e che gli ha cambiato la vita.
Quando è stato il tuo primo incontro con la disabilità?
In Sahara occidentale, nel 2009. Da fotografo più concentrato sulla narrazione per immagini, quindi sul reportage, andai a fare un lavoro sulle persone con disabilità per una ONG. Quello è stato il mio primo progetto importante, durato due anni. È stato l’inizio della mia carriera.
In quel caso ho visto che hai scattato foto a colori concentrandoti sulla sofferenza dei disabili. Nel tuo ultimo libro, invece, le immagini sono in bianco e nero, più artistiche.
Prima ti focalizzavi di più sulla disabilità?
C’è stata un’evoluzione come autore. In quel lavoro (e in altri che sono sul sito) all’inizio il mio approccio è sempre stato del fotogiornalista che cerca di raccontare le sue impressioni sul mondo. Quindi era molto legato alla tematica che affrontavo. Infatti, nel primo progetto, si trovano fotografie di reportage, rettangolari: molto dinamiche, di vita vissuta. Ciò che vedevo lo riportavo con la macchina fotografica.
Come hai identificato, in Sahara Occidentale il mio fine di giornalista era quello di concentrarmi sulla sofferenza delle persone che incontravo: ecco allora che si vedono uomini che strillano o donne incatenate. Ho posto l’attenzione solo sulla disabilità.
All’epoca il mio focus era lavorare per i giornali. Ma pian piano, non soddisfatto del risultato che ottenevo (in questo tipo di commissioni scatti per mesi e poi la pubblicazione sul giornale è di 10 fotografie se va bene) ho iniziato a guardare più a un approccio autoriale, per poi organizzare mostre e libri. Ecco perché la mia fotografia è cambiata e perché quella che vedi sul libro Nessuno Escluso è più riflessiva: sono fotografie di ritratto, che si concentrano anche sul contenuto e sul significato dell’operazione artistica in sé.
Cosa ha cambiato il tuo modo di guardare dietro la macchina fotografica?
Ho incontrato un uomo che si chiama Nicola Barchet. Aveva una bambina con sindrome di down.
E cosa è avvenuto in quell’incontro?
Mentre gli facevo vedere le fotografie realizzate in Sahara occidentale, lui, in quanto insider, mi ha detto che quell’approccio era sbagliato perché genera stereotipi. E quindi mi sono messo a ricercare e ho capito che, quando si tratta di persone con disabilità, ci sono due narrative principali: quella pietistica e quella dei supereroi. La prima vede la persona con disabilità che soffre, che ha bisogno di aiuto medico, di supporto. La seconda è quella che le persone attive del settore chiamano inspiration-porn, ovvero quando le persone con disabilità vengono considerate come dei supereroi, che sormontano le difficoltà e realizzano ciò che la società non si aspetta da loro.
Tipo Alex Zanardi?
Esatto.
Come vedi la disabilità?
Secondo me il centro è parlare della diversità, che è la più grande ricchezza e risorsa che abbiamo. Il mio messaggio parte dalla disabilità, ma si estende e arriva a tutte le altre tematiche, perché in fondo è un invito a comprendere che siamo tutte persone, ognuno con le sue caratteristiche. E una società è migliore se è grado di accoglierci tutti e valorizzarci per le nostre caratteristiche.
Hai voluto vedere la normalità nella disabilità?
Normalità è un termine che non uso. Mi spiego. Lo psichiatra Franco Basaglia diceva che “visto da vicino nessuno è normale”. Se pensiamo al concetto di normalità, cosa vuol dire essere normali? Qual è il metro di paragone? Non esiste la normalità, è sempre legata a un filtro che noi mettiamo in base al nostro background culturale e al nostro contesto sociale nel quale viviamo. Quello che è normale in Cambogia, dove si mangiano gli insetti, può essere assurdo in Italia. Dipende sempre da dove si guarda.
Come hai trovato le persone per il tuo libro Nessuno Escluso?
Ho cercato di viaggiare il mondo per creare un racconto più comprensivo possibile, che includesse tutti i contesti sociali. Volendo raccontare la diversità, era importante visitare il maggior numero di Paesi.
Come ho trovato le storie? Cercandole. Facendomi aiutare da organizzazioni locali che si occupano di persone con disabilità o andando addirittura a bussare di porta in porta. Perché, nonostante ci sia una tendenza a nascondere le persone con disabilità, ce ne sono tantissime. Non è poi cosi difficile trovarle.
Un lavoro lungo.
Cinque anni di progetto. La metà del tempo l’ho passata preparando il lavoro, prendendo contatti, cercando di coordinare i viaggi per affrontare questa tematica non facile.
Perché hai scelto il bianco e nero? Per concentrarti sui volti e non distrarre chi guarda?
Ci sono due ragionamenti alla base. Il primo è quello che dici: di pulire l’immagine e di arrivare all’essenza. Il colore avrebbe generato troppe distrazioni dal messaggio che volevo mandare. E l’altro è che ho cercato di tornare alle origini. Per me, come artista, ma anche per la tematica. E quindi sono voluto ripartire dalla fotografia classica, che è quella del ritratto posato in bianco e nero, in riferimento al libro del fotografo Walker Evans. Volevo resettare la visione che si ha sulla disabilità, ripartire da zero. E quindi il bianco e nero è per me lo strumento più empatico e diretto per parlare all’anima di chi guarda queste immagini.
Come ti ha cambiato questo progetto? Se ti ha cambiato.
Per me è cambiato il modo di vedere. C’è un primo libro di questo progetto che si chiama QuindiciPercento (chiamato così perché il 15% della popolazione mondiale è disabile). Racconta storie provenienti da tre Paesi (Ecuador, Romania e Nepal), ma nelle fotografie c’è ancora tanta concentrazione sulla disabilità. Per questo ho capito che bisognava guardare oltre. E con il libro Nessuno Escluso c’è anche un coinvolgimento attivo da parte di chi viene ritratto. Non è solo un progetto mio, ma di tutti i protagonisti delle fotografie che hanno scelto di essere rappresentati in quella maniera, che si auto rappresentano.
In particolare, come avviene il processo?
È semplice. A tutti ho spiegato cosa stavo facendo e quali erano le mie intenzioni. Creare un progetto che potesse offrire una nuova lettura della tematica mettendo da parte gli stereotipi. Perché spesso quando si parla di disabilità sono sempre gli altri a parlare, non vengono mai interpellate le persone con disabilità. Io ho scelto di togliere la mia visione della tematica per dare spazio a loro.
“Vorrei che foste voi a scegliere la fotografia. Non il modo in cui io inquadrerò e la maniera in cui io farò emergere quello che vedo nella vostra storia, perché quello è un mio approccio artistico. Però, dove la scattiamo, e qual è il soggetto della fotografia, lo scegliete voi, perché dovete decidere in che maniera queste immagini rappresentano la vostra storia”. Questo, in sintesi, ciò che dicevo loro. Ed ecco che nelle foto vediamo che le persone si sono fatte ritrarre con la famiglia, con gli amici, con i parenti, a lavoro e mentre si divertivano. In situazioni di quotidianità, che non ti aspetti quando parli di disabilità. Perché quando parli di disabilità ti aspetti sempre una fotografia di qualcosa che manca e invece qui c’è tutto. Tutta la loro vita.
Bada bene, non ho negato l’esistenza della disabilità. In molte fotografie è anche visibile, ma non l’ho messa al centro.
Infatti, quello che mi ha colpito, è che la disabilità sembra quasi nascosta. Non che tu l’abbia voluta nascondere, ma che non si vede, non emerge.
Prendiamo, ad esempio, una foto che ho scattato in Mongolia. C’è uno sciamano seduto in carrozzina davanti alla sua iurta. Ora, di quella fotografia, quando tu la vedi, non ti concentri mica sul fatto che l’uomo è in carrozzina, ti concentri sul suo tamburo, sul suo vestito, sulla sua iurta. La carrozzina è una parte di questa persona, ma non quella che la definisce. Sai, molto spesso mi chiedono: “Ma sono tutte persone con disabilità?”.
È anche legittima come domanda credo. Perché è una disabilità che diventa bella, artistica.
Per me la bellezza è negli incontri. Io ho cercato la bellezza nelle persone che incontravo. Non riesco a tradurla in parole, perché non sono uno scrittore, ma ci ho provato con le immagini. E questo accostamento, tra immagini belle (che non centrino l’occhio solo su quella cosa, ma sulla persona) e disabilità credo sia un modo di vedere nuovo. Un punto di vista che non è stato mai offerto.
C’è qualcuno che si è rifiutato di partecipare al progetto?
Assolutamente sì e io ho rispettato le scelte. Ma sono stati pochi casi, nella maggior parte le persone sono state felici di partecipare. Io non faccio una fotografia mordi e fuggi. Un’immagine è il frutto di un incontro. Per me l’aspetto importante è il processo di conoscimento. Incontrarci, conoscerci, scambiare. La fotografia è solo una parte dell’incontro.
Ho visto che alle immagini hai affiancato delle frasi.
Te ne leggo una. È di una persona indiana. “Vivo in un piccolo villaggio, su nei monti Niligiri. Curo la terra coltivando ortaggi. Spesso i vicini vengono da me e ci divertiamo a passare il tempo insieme, guardando qualcosa in TV”. Io intervistavo quelle persone per avere una loro testimonianza e scegliere delle frasi iconiche da mettere nel libro, così da raccontare la loro storia.
Quindi racconti la loro vita.
Esatto, la loro quotidianità.
Tra le frasi che hai raccolto mi ha colpito quella del “cacciatore di miele”.
Lei è disabile. È ****. Ti prego di non riportarlo, perché io voglio eliminare questo tipo di informazioni. Nella frase che mi ha lasciato dice: “Mio fratello è l’ultimo cacciatore di miele della zona, è un lavoro pericoloso e io l’aiuto tutti i giorni”. Questo è il suo lavoro, questo è quello per cui lei vuole essere rappresentata. Si pensa sempre che una persona con disabilità non possa essere inserita nell’ambiente di lavoro, ma non è vero. Ho collaborato anche con l’International Labour Organization e una delle più grandi battaglie è quella dell’inclusione lavorativa. In realtà bastano un po’ di accorgimenti per permettere a chi è disabile di lavorare.
In una fotografia che hai scattato in Ecuador, nella descrizione sul tuo profilo Ig hai scritto. “Il silenzio dovrebbe accompagnare la visione di ogni mia immagine”. Perché?
Queste foto sono scattate a pellicola, in medio formato, ed è un processo molto lento e profondo. La mia idea è quella di creare delle finestre attraverso un’opera, attraverso una fotografia, che permetta allo spettatore di fare anche un salto temporale e di immaginarsi arrivare in questo momento a Penipe e vedere questa signora Marisa che fa il giro con la sua carrozzina. E vedere anche il contesto in cui vive: questa strada, queste montagne, le Ande sopra. E mi piace che ci siano tanti livelli. E che alla fine venga fuori anche qualcosa dell’anima attraverso cui io ho voluto raccogliere questo progetto.
Come foto di copertina del tuo libro Nessuno Escluso ne hai scelta una del Kenya. C’è un motivo particolare?
Mi interessava qualcosa che desse il senso della collettività. In questo ritratto, che è di una famiglia in cui c’è una persona con una disabilità (ma non dirò chi è), per me c’è tutto: ci sono i bambini, ci sono gli uomini, le donne, gli anziani, gli animali. È un momento in cui si riposano, sotto l’albero, dalla vita nella savana. Ci vedevo tantissime cose in questa immagine che erano estremamente importanti. Mi dà un senso di inclusione. D’altra parte il titolo del mio libro è “Nessuno escluso”. E loro sono lì, tutti insieme.
Una delle fotografie più felici è quella in cui sono rappresentati dei bambini sorridenti fuori da una scuola in Kenya. Cosa vuoi trasmettere con questa immagine?
Questa foto è un modo per mandare un messaggio di inclusione. È una scuola a Nairobi, Kenya, inclusiva: che ha dei bambini con disabilità che vanno a lezione con gli altri. È un aspetto importante, perché l’inclusione passa anche per la scuola.
Con quale macchina fotografica hai scattato?
Lavoro con delle Hasselblad e delle Rolleiflex. Macchine fotografiche a medio formato, a pellicola. Ho scelto il medio formato perché mi dà la possibilità di avere una risoluzione molto alta e di stampare molto grande. L’altro motivo è che ogni macchina posso fare solo 12 fotografie per ogni rullino; e ciò mi aiuta a concentrarmi e non sprecare tempo con la ripetitività a mitraglietta delle macchine digitali.
Inoltre a me piace non vedere quello che sto facendo, mi permette di sentirmi più unito con l’operazione che sto compiendo. Mentre scatto a pellicola ho la sensazione di prendere un pezzo di materia che viene via con me. Quest’atto per me è magico. E poi le fotografie le vedo mesi dopo; e quindi me le scordo, torno a casa, le sviluppo e me le riguardo. E rivedo, dopo mesi, tutto ciò che avevo vissuto.
Tu dici che ti porti via un pezzo di loro. Ma ho letto che vorresti anche ripotare queste fotografie a chi le hai scattate. Giusto?
Sì. C’è l’idea di riportare le immagini a quante più persone possibile. Questo magari lo riuscirò a fare in 30 anni, perché sono tanti i Paesi che ho visitato.
In quale Paese hai iniziato?
Ecuador. E vuoi sapere in quale Paese ho terminato il progetto? Proprio l’Ecuador. Ho girato il mondo e alla fine sono tornato dove avevo iniziato. E ho incontrato le stesse persone e gli ho raccontato quello che stavo facendo. Questo è bello, perché li rende partecipi di qualcosa.
Hai mantenuto rapporti con loro?
Non con tutti, perché sono stato un momento marginale delle loro vite. Ma con alcuni sì. Ad esempio Manase, un masai del Kenya che fa parte di un network mondiale di popoli indigeni con disabilità. Con lui, ogni volta che viene a Ginevra, ci incontriamo.
C’è una foto del progetto a cui sei più legato?
Non ce n’è una in particolare. Sono legato alla fotografia del pescatore cubano per la sua dimensione rituale legata alla mia ricerca. Quando vado in un Paese, infatti, cerco di influenzarmi leggendo libri che provengono dalla letteratura di quella Nazione. Nel caso di Cuba avevo letto il Vecchio e il mare di Hemingway. Ho sempre cercato, nei mesi che ho passato sull’isola, un pescatore che fosse il “mio” vecchio del libro: un pescatore che avesse disabilità. Non lo trovavo. Fino a che, l’ultimo giorno prima di tornare all’Havana, ero a Bayamo e sulla spiaggia ho visto quest’uomo. Ci siamo incontrati, gli ho chiesto se voleva partecipare, e lui mi ha detto: “Vuoi raccontare la mia storia? È sulla mia barca. Perché ogni giorno prendo il largo e vado in mare”.
Un lavoro che quindi è passato anche attraverso lo studio dei libri legati al posto che hai visitato.
Sì, però non è un lavoro giornalistico. Non racconto niente con le mie fotografie. Spesso non avviene niente, sono dei ritratti. Tutto quello che ho cercato di mettere dentro sono delle influenze della mia visione che in questo caso è volutamente di ritrattistica, fotografia classica, semplice.
Pura.
Esatto. Ho cercato di sottrarre. Di sottrarre la mia visione stereotipata. Ho cercato di sottrarre tutto quello che potevo per arrivare all’essenza.
Le Marche, la tua regione di origine, ti hanno influenzato?
Considera che la prima parte in Ecuador è stata supportata proprio dalla Comunità di Capodarco (provincia di Fermo). Penipe, dove sono stato la prima volta, è dove la comunità ha il suo centro in Ecuador. Sono stati loro il primo contatto. Quindi sì, le Marche mi hanno influenzato. La ragione credo sia legata alla morfologia del territorio, all’ispirazione che certi paesaggi di danno.
Qual è il tuo rapporto con la religione? Ho visto che ci sono molte foto di templi.
Non ho un rapporto particolare con la religione. In questo progetto mi ci sono avvicinato per cercare persone con disabilità in questo mondo. Ho cercato sin dall’inizio preti e monaci buddisti, ma non li ho trovati. In Mongolia invece sì, molti sciamani. E questo aspetto, in molti contesti, genera quella che viene chiamata witchcraft: si pensa che una persona disabile, in quanto tale, ha qualche potere magico. Ma non in Mongolia, dove la disabilità non influisce sulla figura dello sciamano. Qui lo spirito ti sceglie per la tua anima, non importa chi tu sia. E ho trovato che questo fosse un messaggio di grande inclusione.
Come la foto delle due ragazze irlandesi che si abbracciano.
Questa è una fotografia che ho trovato dopo mesi. L’avevo dimenticata, poi, quando ho visto lo sguardo penetrante di lei, ho voluto riprenderla. Avevo però solo frasi separate, perciò le ho contattate nuovamente e gli ho chiesto di inviarmene una singola, insieme. “Per promuovere il benessere di tutti, le persone hanno bisogno di sostegno, non di tortura. La nostra speranza è che un giorno le persone aprano le porte, termino gli abusi e ci permettano di vivere in libertà insieme agli altri”.
Nella descrizione Ig della donna di Tarau, Ecuador, hai scritto: “Questa è una delle migliori”. Perché?
Immagina che Tarau è un posto dove devi camminare per ore prima arrivare. Una volta giunto in cima, trovi soltanto questo villaggio di contadini che vivono in delle capanne, case raffazzonate. Chi trovo su? La signora Maria Elena con la sorella, che oltre a fare le contadine gestiscono una farmacia di alta montagna. E quindi sono indispensabili a tutta la loro comunità: questo è fantastico. Perché siamo abituati a considerare le persone con disabilità come qualcosa di accessorio, e invece ci sono tanti contesti sociali dove possono essere un perno della società. Anche il pescatore cubano, per esempio, è fondamentale nel suo villaggio: insegna ai giovani a pescare. Non solo esce fuori tutte le mattine, ma insegna anche agli altri.